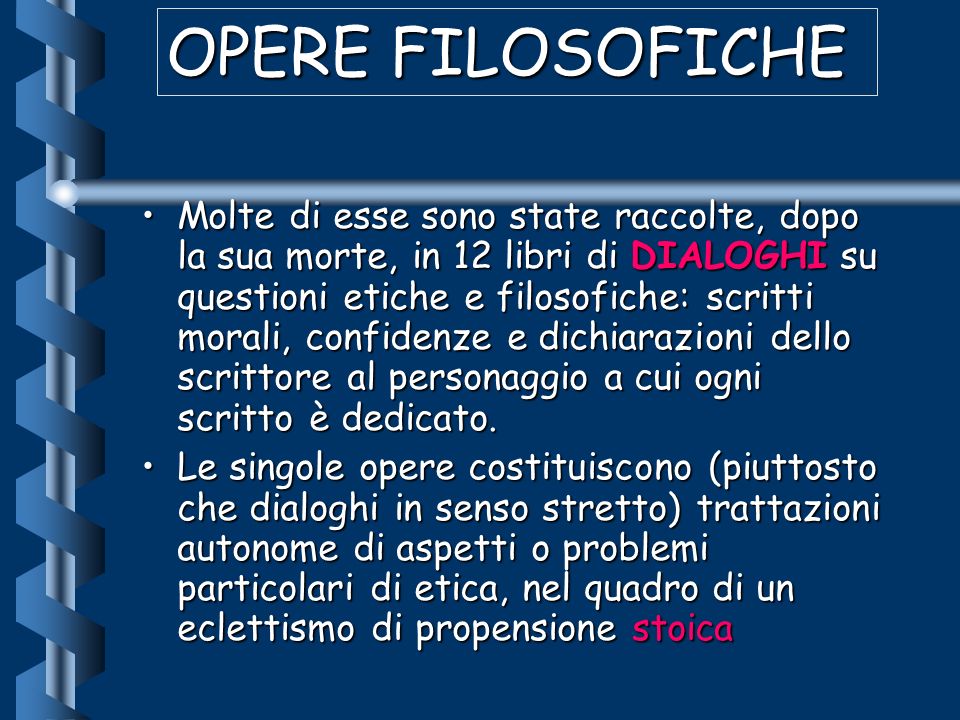Le opere filosofiche di Seneca trattano argomenti morali che lo rendono uno tra i più influenti moralisti della letteratura europea. I "Dialogorum Libri XII" comprendono, come suggerisce il titolo, 12 libri, nei quali vi sono 10 opere di argomento filosofico (Ad Lucilium de providentia, Ad Serenum de constantia sapientis, Ad Novatum de ira, Ad Marciam de consolatione, Ad Gallionem de vita beata, Ad Serenum de otio, Ad Serenum de tranquillitate animi, Ad Paulinum de brevitate vitae, Ad Polybium de consolatione, Ad Helviam matrem de consolatione). Con “Dialogorum” non bisogna pensare a dei veri e propri dialoghi tra personaggi bensì a un ragionamento filosofico condotto con metodo dialettico. Seneca, infatti, usa tale termine perché attua una sorta di confronto con un personaggio fittizio, per questo vi è la presenza del cosiddetto “Tu diatribico”. In “Ad Lucilium de providentia”, Seneca risponde all’amico Lucilio che gli ha chiesto il motivo per cui i buoni sono colpiti dai mali seppur l’universo è retto dalla provvidenza divina, così come affermato dallo stoicismo. Il filosofo risponde dicendo che quelli non sono i veri mali ma prove volute dagli dei al fine di sottoporre i buoni per aiutarli moralmente. In “Ad Serenum de constantia sapientis”, Seneca, parlando ad Anneo Sereno, dimostra la tesi stoica per cui il saggio non può essere colpito da nessuna offesa, dato che la sua forza e la sua superiorità morale lo rendono immune da qualsiasi attacco. Il saggio crede che l’unico bene sia la virtù, la quale lo tiene lontano da ogni danno. In “Ad Novatum de ira”, Seneca si propone di combattere l’ira, il sentimento più pericoloso. Egli ritiene che l’ira non è utile affatto perché prodotta da un istinto che offusca la ragione, per questo si preoccupa di trovare un rimedio per poterla prevenire o placare. Il filosofo porta Caligola come esempio di ira, visto come una bestia furiosa e assetata di sangue. In “Ad Marciam de consolatione”, Seneca consola Marcia, figlia di Cremuzio Cordo, sofferente per la morte prematura del figlio. Il filosofo dimostra come la morte non sia negativa bensì sia la salvezza dell’anima. Alla fine dell’opera, Seneca immagina che il giovane sia accolto dal nonno in cielo e sia posto in mezzo ai grandi uomini. In “Ad Gallionem de vita beata”, Seneca espone la dottrina morale stoica che vede la virtù come sommo bene, polemizzando gli epicurei che, al posto della virtù, pongono il piacere. In “Ad Serenum de otio” Seneca, rivolgendosi nuovamente ad Anneo Sereno, affronta il problema della superiorità della vita attiva o contemplativa. Il saggio, infatti, seppur ritiratosi a vita privata, deve continuare a dare il proprio contributo all’umanità. In “Ad Serenum de tranquillitate animi”, dedicato sempre ad Anneo Sereno, costituendo una “trilogia a Sereno”, Seneca immagina che il giovane chieda a lui consiglio e aiuto poiché si trova in una condizione di instabilità spirituale. Il filosofo descrive l’animo inquieto e tormentato di Sereno e, al tempo stesso, indica dei possibili rimedi per raggiungere la tranquillità d’animo. In “Ad Paulinum de brevitate vitae”, dedicato all’amico Paolino, Seneca sostiene che gli uomini si lamentano senza una valida ragione della brevità della vita. Il filosofo ritiene che la maggior parte degli uomini spreca il suo tempo e che solo il saggio ne fa buon uso perché si dedica alla ricerca della verità e alla saggezza. In “Ad Polybium de consolatione”, dedicato a Polibio, potente liberto dell’imperatore Claudio, in occasione della morte di un suo fratello, Seneca riprende i temi della consolatio, affermando che la morte non è un male e che è inutile piangere chi non è più in vita poiché è meglio aver conosciuto la persona morta che non averla conosciuta affatto. Seneca, in realtà, mirava ad influenzare le decisioni di Claudio e ad essere richiamato dall’esilio, rivolgendo una vera e propria supplica al sovrano. In “Ad Helviam matrem de consolatione”, dedicato alla madre che soffre la scomparsa del figlio, Seneca invita la madre a pensare che lui sia sereno, dedito agli studi, alla filosofia e alla ricerca della verità. Nell’opera Seneca impianta un’implicita equivalenza fra esilio e morte. Nelle opere filosofiche rientrano anche i trattati (De Clementia, De Beneficiis, Epistulae morales ad Lucilium, Naturales Quaestiones), in cui vi è la polemica e un ricorso agli esempi della storia greca e romana. Il “De Clementia” è un trattato filosofico politico in cui Seneca esalta la monarchia illuminata. L’opera è dedicata a Nerone, da poco imperatore, che viene elogiato per possedere la virtù più alta, la clemenza. Questa virtù distingue il buon sovrano dal tiranno e garantisce stabilità all’impero. La clemenza non va però scambiata con la compassione, considerata un vizio, un cedimento della razionalità a impulsi emotivi. Il “De Beneficiis” è un trattato dedicato all’amico Elbuzio Liberale, nel quale Seneca da insegnamenti sul giusto modo di fare e ricevere benefici, fondamento di convivenza civile e della vita sociale. Le “Epistulae morales ad Lucilium” sono l’opera filosofica più importante di Seneca, in cui il filosofo esprime, in modo maturo e personale, la sua visione della vita e dell’uomo. L’opera comprende 124 lettere, destinate all’amico Lucilio, distribuite in 20 libri, anche se in realtà si dice che la raccolta è incompleta. Il tema principale delle lettere è il progresso fatto da Lucilio che lo porta a capire che nella sapienza risiedono i veri valori e che è possibile provare gioia soltanto attraverso la lotta contro le passioni. Seneca raccomanda a Lucilio di astenersi da qualsiasi attività frivola e di liberarsi dai falsi giudizi. Seneca, come dottrina, propone all’amico lo stoicismo, seppur citi più volte l’epicureismo e i suoi temi come l’ozio, l’amicizia e il disimpegno. Temi principali sono anche il tempo e la morte: per Seneca il tempo va stimato in modo qualitativo e non quantitativo e la morte deve essere vista come la liberazione da tutti i mali dell’esistenza. Le “Naturales Quaestiones” sono un trattato di scienza naturale suddiviso in 7 libri dedicati a Lucilio. Seneca ritiene, come gli antichi, che alla base della filosofia ci fosse la natura, per questo bisognava esserne a conoscenza. Con quest’opera, Seneca mira a liberare gli uomini dalle paure che nascono dall’ignoranza dei fenomeni naturali e ad insegnare loro il giusto uso degli elementi naturali. Per Seneca la ricerca scientifica è fondamentale per l’evoluzione perché, attraverso lo studio dei fenomeni naturali, l’uomo può portare alla luce le verità nascoste.